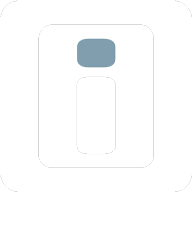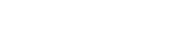Percorsi per l'internazionalizzazione del sistema Umbria
A cura di Federico Fioravanti
Intervento di Luca Ferruccidocente Università degli Studi di Perugia
 La restrizione dei mercati domestici ha spinto le imprese a guardare all'estero. Spesso però senza avere la capacità di gestire i nuovi mercati. Per l'Umbria, regione la cui economia vive di piccole imprese, una difficoltà in più...
La restrizione dei mercati domestici ha spinto le imprese a guardare all'estero. Spesso però senza avere la capacità di gestire i nuovi mercati. Per l'Umbria, regione la cui economia vive di piccole imprese, una difficoltà in più...
L'Umbria strutturalmente ha degli indici di apertura verso i mercati esteri inferiori rispetto alla media italiana e comparativamente anche rispetto alle regioni limitrofe. Sappiamo oramai da tempo che ci sono circa sei punti percentuali di differenza tra il valore delle esportazioni e il PIL umbro, e il valore delle esportazioni e il PIL nazionale. Quindi c’è un deficit strutturale che viene da lontano e che forse la crisi per taluni aspetti ha acuito. Ma è un problema vecchio per questa regione.
Trattare il problema dell’internazionalizzazione come solo un problema esportativo di merci e prodotti è oggi più che mai limitativo. Non solo perché l’industria che è il cuore fondamentale dello sviluppo di un paese, è comunque circa il 30% del valore aggiunto di un’economia moderna, ma anche perché, se vogliamo davvero istituire legami forti sulla frontiera dell’internazionalizzazione, dobbiamo guardare anche alle altre facce dell’export.
Un sistema si internazionalizza se almeno riesce a far evolvere insieme, in modo sinergico, cinque diverse facce.
La prima, certo, è quella più immediata che tutti noi percepiamo: l’internazionalizzazione di merci e prodotti, sulle quali l’Umbria ha dei deficit strutturali.
La seconda è un’internazionalizzazione delle persone. Quando cioè un sistema si internazionalizza ci sono degli individui, ci sono dei flussi di persone, cresce una mobilità che negli ultimi venti anni noi abbiamo constatato sia come Paese sia come regione. Da questo punto di vista l’Umbria è sopra la media nazionale, come percentuale di immigrati rispetto alla popolazione residente. Ma la composizione di questi immigrati suscita qualche perplessità, perché esportiamo cervelli, cioè capitale umano qualificato e importiamo invece una manodopera generica che oramai non serve più per ricostituire le basi della competitività delle nostre imprese. Su questo bisogna riflettere. Così come bisogna riflettere sul mondo della formazione, sia in Umbria che in Italia.
Ma a proposito della internazionalizzazione vorrei ricordare quello che, tre anni fa, mi diceva un collega di Cambridge: in Gran Bretagna hanno attivato un progetto importante dove vengono selezionati dei cervelli nascenti (chiamiamoli così), già nelle scuole dell’obbligo, quindi i futuri geni, che vengono incanalati in percorsi di eccellenza per imparare la lingua cinese. Perché imparare la lingua cinese non è come imparare l’inglese, o altre lingue indoeuropee dove la facilità è maggiore: per imparare il cinese bisogna intraprendere percorsi scolastici di dieci, quindici anni. Non basta un master di un anno. Ecco, in Gran Bretagna selezionano dei ragazzi già nelle scuole dell’obbligo. E li guidano lungo un percorso collaterale, parallelo alla formazione scolastica. Questi studenti, se saranno bravi, avranno accesso ai migliori college universitari come appunto Cambridge. Queste sono delle vere politiche nazionali. Politiche che guardano a un’internazionalizzazione delle persone per creare quel capitale umano qualificato che serva a un paese da qui a dieci anni. Perché lavorare sull’internazionalizzazione non è solo una emergenza che nasce dalla crisi di questi ultimi anni ma vuol dire costruire le basi della competitività futura.
Poi c'è la terza fascia dell’internazionalizzazione. Se vogliamo andare soprattutto nei mercati culturalmente distanti, qualche volta anche geograficamente lontani, è necessario investire in questi mercati. Cosa significa? Significa attivare delle modalità di internazionalizzazione diverse dal dire: vado in fiera e provo a vendere, provo a esportare. Vuol dire investire e, di conseguenza, avere sedi radicate in questi contesti. Quindi c’è un’internazionalizzazione che guarda anche al capitale finanziario. Capace non solo di attrarre investitori nel nostro Paese o nella nostra regione, ma anche di indirizzare e sostenere le imprese nei luoghi dell'investimento.
La quarta faccia dell’internazionalizzazione è quella dei servizi. Insomma, se nell’economia moderna i servizi pesano per il 70%, dovrà pur essere fatta una riflessione su quali possono essere i servizi esportabili all'estero. Non vendere prodotti ma offrire know-how, capacità, intelligenza. E i servizi, attenzione, non sono solo le grandi cose degli scienziati ma riguardano anche temi “tradizionali”. Quando abitavo in Toscana, qualche anno fa, era pervenuta alla Regione la richiesta di portare circa cinquanta giovani a mettere in piedi un mercato ambulante nelle principali città attorno a Francoforte. Questi giovani avrebbero dovuto essere impegnati sette giorni alla settimana. Era lavoro, era internazionalizzazione. Non servizi high tech ma low tech ma capaci comunque di creare ricchezza e trainare delle filiere, magari agroalimentari. Naturalmente iniziative come questa si legano ad un percorso, fatto anche di formazione: aiutare dei giovani a diventare imprenditori, alimentando la loro voglia di andare a fare gli ambulanti, perché l’ambulantato è una tipicità dell’Italia, o almeno così viene percepita e avvertita da molti stranieri. E poi pensate cosa significa per la Francia, lo dico spesso, il fatto di avere avuto aziende come Carrefour, Auchan o Leclerc, che sono andate all’estero ad aprire catene di ipermercati e supermercati. Alcuni colleghi francesi mi spiegavano che se si disaggregassero i dati si troverebbe la conferma che queste aziende generano più ricchezza di quella prodotta dalla Renault o dalla Peugeot.
Attenzione, questo non vuol dire deindustrializzare ma è la prova che un sistema che si apre all’internazionalizzazione sa anche guardare alla parte strategica dei servizi.
La quinta faccia dell’internazionalizzazione, e in questo tavolo ne abbiamo una autorevole rappresentanza, è quella rappresentata dalle istituzioni. Pensate alla rete delle Camere di Commercio estere, ai loro saperi, alle loro relazioni. Pensate a come le istituzioni possano diventare dei riduttori dell’incertezza decisionale degli imprenditori nel programmare investimenti. Paure ed incertezze comprensibili quando si deve operare in mondi così distanti. Anche le grandi banche potrebbero fare bene questo mestiere quando sono presenti all'estero. Ora, purtroppo, mi sembra che siano prese da ben altre questioni. Ma sul fronte della internazionalizzazione è fondamentale il lavoro che possono svolgere le Camere di Commercio e le Regioni. Oppure le università, capaci di allacciare dei legami a livello internazionale.
Abbiamo da poco citato l'esempio della siderurgia, che pesa per un terzo nell'export dell'Umbria.
Come andrà in futuro non dipende solo dalla congiuntura del settore: l'Umbria sta giocandosi la partita del cambiamento degli assetti proprietari della siderurgia ternana. E sappiamo che quando cambia un soggetto proprietario, cambiano spesso le strategie e le politiche di investimento.
Perciò io mi chiedo: possono le istituzioni fare qualcosa, certo senza agire in modo protezionistico? Il nuovo proprietario non parla tedesco ma finlandese. E con la Finlandia l’Università di Perugia ha dei buoni legami, grazie alla mobilità di studenti e docenti con alcune università di quel paese. Perché non provare a costruire un progetto con questa multinazionale? Ad esempio provando a chiedere quale sia il percorso più utile e più efficace per le necessità di quella grande azienda che devono affrontare i nostri studenti? Magari inviandoli per sei mesi o un anno in alcune università finlandesi a studiare, a laurearsi, per poi, in futuro, poter finalmente arrivare ad avere non solo chi compra aziende umbre ma una classe dirigente umbra che lavora in modo stabile nel management di imprese multinazionali straniere?
E' un tema sul quale vale la pena lavorare anche perché nel nostro territorio sono presenti anche altre multinazionali con assetti esteri.
Come spiegava Esposito, dieci anni fa in Umbria c’erano più imprese esportatrici come numero assoluto ed era presente anche qualche proto distretto, che non era proprio quello della tradizione toscana, marchigiana o veneta. Ma qualche embrione di distretto c’era.
La storia umbra è una storia diversa che non ha gemmato e generato i distretti come in altre regioni contigue, in quella forma diciamo più o meno decattiniana o marshalliana, di migliaia di imprese specializzate. Il percorso umbro si è innestato su un modello diverso: quello delle medie imprese di eccellenza. Molte di queste aziende, presenti negli anni ‘80, sono tramontate, basti pensare ai grandi nomi del settore alimentare. Ma ce ne sono altre, pensiamo agli Angelantoni o ai Colussi, che hanno investito all’estero e sono ormai da tempo presenti in importanti mercati. Possono queste medie imprese svolgere la funzione, in un certo qual modo, di tutor di altre piccole imprese? Perché dal ‘91 ad oggi, l'export umbro è cresciuto sempre un po' di più in percentuale rispetto a quello della Toscana o delle Marche. L ’Umbria ci prova ma è un’Umbria limitata perché sono poche imprese, se abbiamo sei punti percentuali di differenza nella propensione all’export. Qui il tema vero è quello di provare a coinvolgere un maggior numero di imprese, anche di piccole dimensioni, e per farlo certe medie imprese possono essere di aiuto.
***********
Professor Ferrucci, senza denari serve più organizzazione oppure uno sforzo di fantasia particolare.
Sì, serve senz’altro un’organizzazione che non sia elefantiaca, che sia basata su dei criteri di reclutamento basati sul merito, sulla capacità delle persone e non sulle appartenenze.
Una organizzazione che sia capace di coinvolgere dal basso la domanda di servizi delle imprese e che sia capace di coalizzarla verso alcuni mercati. E che sia capace, qualche volta, di collaborare con altre organizzazioni per non generare duplicati e ridondanze, quindi spreco aggiuntivo di risorse. Per cui meno risorse, più organizzazione, ma un’organizzazione fatta bene.
Con meno soldi a disposizione è in atto una dura selezione tra le aziende.
Meno soldi, più selezione. E' quello che è accaduto. Ma non è detto che chi sopravvive sia sempre il migliore. Nella crisi alcuni imprenditori si salvano perché sono bravi. Vanno applauditi perché sono l'esempio di un capitalismo virtuoso, quello che tutti vorremmo. Ma c’è anche qualcuno che si salva perché ha buone relazioni con il mondo delle banche oppure perché ha buone relazioni con grandi imprese pubbliche, Finmeccanica, ENI o ENEL e quant’altro, ma che, qualche volta, i suoi fornitori se li sceglie non solo in base a criteri di merito.
Ben venga quindi la selezione ma che premi davvero le imprese serie, rigorose, competitive, quelle che stanno sui mercati internazionali e non quelle abbracciate al potere della politica, delle grandi aziende pubbliche o delle banche.